N.6 Maggio 2025
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors
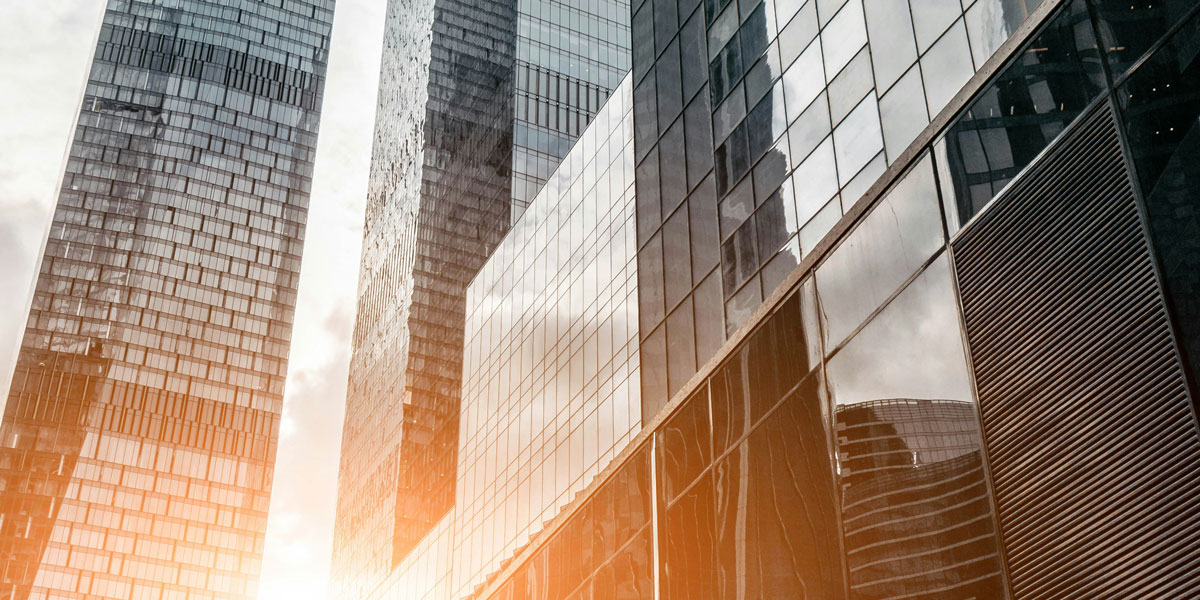
La relazione illustrativa del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici in attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, nel descrivere la nuova disciplina generale del partenariato pubblico-privato, definisce tale istituto come una “operazione economica”, in tal modo generando una netta cesura con il Codice dei contratti pubblici approvato a mezzo del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, il cui art. 180 disciplinava il “contratto di partenariato pubblico privato”, definendolo oneroso.
La nuova definizione del partenariato pubblico-privato viene giustificata in ragione della complessità di tale “fenomeno”, riferibile alle svariate tipologie contrattuali previste e catalogate dal nuovo Codice, come confermato dal comma 3 dell’art. 174, secondo il quale il “nuovo” partenariato è strutturato su un rapporto genere/specie esistente tra il partenariato pubblico-privato, le concessioni e le altre tipologie contrattuali, quali la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità.
La inedita natura giuridico-funzionale del partenariato pubblico-privato rileva altresì in considerazione degli importanti riflessi economici ad esso collegati, atteso che il partenariato va inteso come strumento di cooperazione fra il settore pubblico e gli operatori privati nella realizzazione di un’attività che è rivolta a coniugare il perseguimento di finalità di interesse generale, la salvaguardia di vincoli di bilancio e la valorizzazione del contributo di soggetti privati in termini di apporto finanziario e di competenze specifiche.
La descrizione normativa del nuovo partenariato pubblico-privato, oltre che valere come definizione giuridica del “fenomeno” in argomento, altresì certifica l’aspirazione ad un radicale e generale cambiamento delle scelte di politica economica; cambiamento basato sugli indirizzi delle istituzioni comunitarie secondo i quali i contratti pubblici – normalmente utilizzati dalla P.A. per svolgere la propria azione e per conseguire i propri fini o bisogni – vanno considerati come strumenti dell’intervento pubblico nei vari settori dell’economia al fine di stimolare una crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva”, come auspicato già nella Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020” del 3 marzo 2010.

Si tratta, in buona sostanza, di utilizzare il partenariato pubblico-privato come strumento strategico in grado di assicurare il perseguimento dei vari obiettivi di “transizione” predicati dalle politiche dall’Unione Europea, valorizzando il notevole apporto economico in questo frangente ancora assicurato dal PNRR, strumento di programmazione economica la cui attuazione è basata su meccanismi procedurali di matrice euro-unitaria, caratterizzati da accentuata specificità tecnica e capacità innovativa.
In tale ottica, il coinvolgimento delle imprese private si rivela determinante, considerata la natura cooperativa, quindi mutualistica, della relazione economica che si genera tra il soggetto pubblico e quello privato, entrambi assuntori di specifiche responsabilità funzionali, come si ricava dalle disposizioni generali del nuovo Codice.
Ed infatti, come previsto dall’art. 174 del Decreto Legislativo n. 36/2023, una operazione di partenariato pubblico-privato sussiste ed è riconducibile a tale istituto solo e soltanto se ricorrono le seguenti caratteristiche:
- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
A fronte di tali dettagliati ed inderogabili presupposti operativi, di rilievo si rivela il rinvio alla capacità generale di diritto privato, al fine di consentire alle amministrazioni di ricorrere a figure contrattuali atipiche, così da estendere le forme di partenariato pubblico-privato, ferma la sussistenza delle caratteristiche fissate dal legislatore e con la specificazione che i contratti atipici debbono essere comunque diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela; trattasi, quindi, di opzione giuridica ed operativa icasticamente tesa a perseguire lo scopo mutualistico predicato dal legislatore.
Il rafforzamento del ruolo pubblico si coglie anche nella creazione del partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, codificato dal comma 4 dello stesso art. 174, che si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, nonché necessariamente disciplinato dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e dalle altre norme speciali di settore.
L’analisi normativa sin ora svolta evidenzia un tema di fondo che non può essere taciuto e che in qualche modo deriva dall’esperienza concretamente maturata in materia di partenariato pubblicoprivato; ci si riferisce, nello specifico, alle criticità che potrebbero derivare dalla oggettiva sovraesposizione finanziaria degli operatori privati, in termini di obblighi e rischi assunti, tali da scoraggiare il ricorso al partenariato pubblico-privato, come accaduto nella vigenza del Codice del 2016.
Sta di fatto che la portata innovativa del nuovo Codice si coglie proprio su questo aspetto, atteso che, come si legge nella Relazione illustrativa, per raggiungere l’obiettivo di estendere le forme di partenariato pubblico-privato è fondamentale individuare, in un’ottica multidisciplinare, strumenti che incentivino le imprese a partecipare alle gare.
Il catalogo di tali strumenti è riposto nell’art. 175 del nuovo Codice, il cui primo comma prevede l’adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, in guisa tale da garantire in primo luogo la conoscenza e la diffusione di esigenze collettive da soddisfare con la cooperazione pubblico-privata, ma anche la creazione di una canale di comunicazione in grado di generare un processo dialettico tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, in qualche modo in grado di descrivere e supportare l’indirizzo politico sotteso alle singole operazioni di partenariato, con evidente applicazione del principio di sussidiarietà, declinato sul piano orizzontale.
Il comma 2 del citato art. 175 prevede, inoltre, che il ricorso al partenariato pubblico-privato sia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, valutazione che si incentra sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale.
Le prescrizioni operative descritte dalla norma citata sono evidentemente volte a garantire una complessiva disamina tecnica, finanziaria e politica della astratta ipotesi di operazione basata sul partenariato pubblico-privato, non senza trascurare, sempre in termini di confronto del rapporto costi/benefici, la comparazione con l’ipotetico contratto di appalto di pari oggetto, in tal modo recuperando la preferenza dello schema contrattuale tradizionale, in relazione alla specifica operazione progettata.
Peraltro, il riferimento alla “capacità di generare soluzioni innovative” conduce ad ipotizzare che i processi di verifica descritti dalla norma in esame possano essere praticati anche accedendo agli strumenti delle Strategie Generative AI, in modo tale da consentire la creazione di data base utili per ispirare e strutturare future operazioni pubblico-private.
In questa ottica va apprezzata la scelta di pubblicare ed aggiornare periodicamente sul portale di monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.
Ciò in quanto l’evidenza anche telematica delle finalità pubbliche sottese all’operazione di partenariato pubblico-privato e dei risultati bilateralmente conseguiti è oggettivamente in grado di generare fiducia nel ceto imprenditoriale e di sollecitare l’attenzione delle imprese, considerato che l’esito positivo delle operazioni già realizzate finisce per certificarne la ripetibilità.
Lo sforzo riformatore azionato mediante la delega del 2022 e la scelta di rivedere il Codice valorizzando l’esperienza, teorica ed applicativa, della Giustizia amministrativa, possono indubbiamente fornire il giusto impulso al partenariato pubblico-privato; tuttavia, la crisi sistemica che si sta diffondendo a livello planetario, mettendo in discussione il consolidato ordine internazionale, potrebbe finire per fagocitare risorse altrimenti destinate al rilancio economico ed agli obiettivi delle transizioni, compromettendo il rispetto di principi ed obiettivi euro unitari, con buona pace degli sforzi compiuti per rilanciare il partenariato pubblico-privato.
